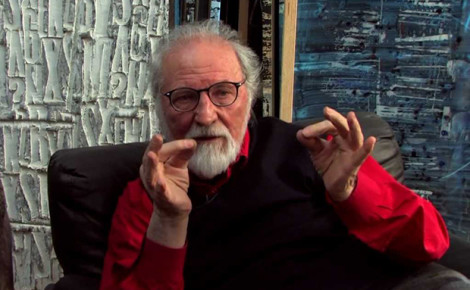Udine, 20 novembre 1939.
L’inverno non era ancora inverno, perlomeno sul lunario appeso al muro.
Era novembre, ma un novembre freddo, coi rami degli alberi gelati e la galaverna che al mattino ricamava geografie di ghiaccio sui vetri delle finestre , intente a ingaggiare battaglia contro i fendenti di bora e le lame di tramontana che soffiavano in raffiche furiose, abrasive come polvere di vetro sulla pelle delle guance o delle mani.
Immobile accanto alla finestra, Giorgio guardò giù, verso la strada. Il corso era quasi deserto. Un uomo camminava a passo svelto. Passò una bicicletta, sferragliando. Un merlo volò via da un ramo.
La luce del primo mattino incominciava a risvegliare il mondo. Il profilo di una casa si stendeva, una forma sbucava dall’ombra, lo spazio si andava dilatando come un corpo che rinasce a pelle nuova.
Vide un bambino, fuori da una porta. Accucciato sulle ginocchia, i calzetti a ricadere sulle scarpe, in testa un berrettino color topo. Stringeva una trottola in mano. Il bambino alzò gli occhi alla finestra da cui Giorgio lo stava osservando: gli sguardi si incrociarono un momento, in uno scambio di curiosità. Poi, torcendo il polso con destrezza, il bambino impresse alla sua trottola un’abile e lunga traiettoria, e la trottola prese a prillare: sgranava la sua sagoma di legno in un convulso moto circolare, sbatteva sul gradino di una casa, imprimeva alla sua folle corsa mozza l’imprevisto di una nuova diagonale, cominciava a dare segni di stanchezza, si inclinava leggermente su se stessa, si arrendeva a un rallentamento incerto, sospeso tra resistenza e stasi.
Infine, scantonando di fatica, la trottola di legno si arrestò.
Giorgio sentì in sé quel movimento: lo stordimento franto del girare, la pace riscoperta della stasi. Poterlo dire, pensò. Meglio: poterlo disegnare. Poterlo riprodurre in qualche modo, riuscire a evocarlo di nuovo.
Il gatto gli si strusciò ai polpacci, geloso di uno sguardo e un’attenzione che a un tratto parevano escluderlo per scivolare fuori, oltre il cortile.
Giorgio si accucciò, lo prese in braccio, impresse una lunga carezza al pelo tigrato del soriano, avvertendo sotto i polpastrelli la groppa che cedeva e si inarcava in un fremito colmo di piacere.
C’era un profumo dolce, nella stanza. Un sentore di zucchero e farina. D’un tratto ripensò alla sera prima: il giorno del suo compleanno.
Aveva compiuto dieci anni: il primo ingresso nell’età a due cifre. Sua madre gli aveva preparato una torta a base di mele, e lui aveva aperto il suo regalo – una copia dell’Isola del tesoro – sentendosi al centro del mondo, anche se una parte di quel mondo era entrata in guerra da mesi.
Il libro non gli era dispiaciuto, ma era stato suo fratello Sergio a intuire e a mettergli in mano – avvolto in carta da pacco – ciò che Giorgio più desiderava: un pennello, una piccola tela, tre o quattro tubetti di colori.
Giorgio aveva svitato un tubetto, sfiorando appena con il polpastrello la consistenza fresca e promettente svelata dall’apertura.

I colori gli parlavano da sempre, e a lui piaceva starli ad ascoltare.
Ogni colore aveva una sua lingua, e usava un diverso alfabeto.
Il rosso parlava con foga e si esprimeva senza timidezze. Era il colore della combustione, e tuttavia della materia viva: i papaveri di campo, un melograno, il sangue che pulsava nelle vene. Il giallo era ambiguo e invadente, ma sapeva comprendere gli errori, le debolezze della consunzione: la fragilità dell’erba che si secca, il pus della ferita che si infetta, la patina dei denti quando invecchia. Il verde era fresco e leggero come una sera d’aprile, e poteva affondare negli occhi come un morso in un frutto maturo.
Il nero era violento ma sincero, il lilla era timido e indeciso. Il bianco poteva essere puro, ma anche solo pavido e insapore.
Giorgio aveva la nitida impressione che il mondo sarebbe stato piatto – non solo spento, ma piatto – senza l’intervento dei colori. Un mondo come monco, mutilato, schiacciato su due dimensioni: terra e cielo, orizzontale e verticale. Era la luce – erano i colori – a dargli un corpo, a renderlo una casa, a regalargli fiato e vibrazioni, a garantirgli una profondità.
Quando avevano finito di mangiare anche l’ultima fetta di torta, sua madre, la sera precedente, lo aveva d’un tratto sorpreso con una frase inattesa: “C’è un altro regalo, per te.”
Alzandosi, gli aveva fatto un cenno. I suoi due fratelli più grandi avevano ammiccato fra di loro, mentre lui già seguiva sua madre fino al piano di sopra, incuriosito. Oltre l’ultima rampa di scalini, lei si era limitata a spalancare la porta della stanza di sinistra, nel sottotetto della grande casa immersa nel silenzio della sera. Poi si era fatta da parte, lasciando che ad entrare fosse il figlio.
Giorgio aveva mosso qualche passo. Nella penombra, il vuoto. Solo il vuoto.
Il vuoto di un grande vano nudo – a parte una vecchia cassapanca addossata contro una parete – e la pallida luce di un lampione che filtrava con circospezione dalla finestra aperta sulla strada.
Giorgio aveva scrutato sua madre con un punto di domanda nello sguardo, mentre d’un tratto lei gli sorrideva: “ D’ora in poi questa stanza è tutta tua.” Si era sentito assicurare. “Puoi farci quello che vuoi.”
Lui aveva avvertito un groppo in gola. Uno spazio per sé, in esclusiva. L’aveva sempre sognato. Un piccolo mondo segreto per dare forma al resto, al mondo vero, traducendolo in forme e colori. E adesso si preparava a entrarci, a stringerci un patto, a farlo suo.
Giorgio depose a terra il gatto e si avvicinò a un angolo del muro. Mentre si inginocchiava sull’assito, il legno gemette e scricchiolò.
Sfilò da una tasca un cacciavite e studiò il punto esatto, alla sua destra, dove la patina di calce formava una leggera bombatura percorsa da una fessura che si ramificava verso il basso: una fragile traccia del tempo, una trasgressione dei mattoni, una pallida vena screpolata che forse si poteva assecondare.
Lo spazio lo aspettava con pazienza: era un muto corpo vivo, e lo invitava.
Con la punta del cacciavite, su cui prese a picchiare un martello, praticò sulla parete cinque fori. Se ne aggiunsero altri due, un po’ più esterni – quasi fossero satelliti dei primi – e subito dopo altri ancora.
Non c’era un ordine preciso, né una precisa geometria.
Poi scelse colori e materiali valutando rapporti e consistenza, dissonanze e prepotenti simmetrie. Erano piccoli oggetti, dettagli che sembravano sposarsi per passione oppure per contrasto, per destino o per casualità: qualche sasso, un nodo di radice, tre bacche più rosse del fuoco, la piuma verdeviola di un pavone, un frammento di smalto color ciano, una biglia di vetro scheggiata che prese a occhieggiare dal muro come l’occhio di un ciclope domestico, mezzo complice e mezzo sfacciato.
Il mondo era strano, e complesso: Giorgio, a volte, non lo capiva.
La guerra, ad esempio. La guerra. Quella nuova e quella di prima, la guerra del Quindicidiciotto, di cui suo zio gli aveva raccontato mostrandogli la cicatrice che si era guadagnato da ragazzo, combattendo sul fronte, a Tolmino.
Giorgio diede col martello un colpo secco. Inserì nel nuovo buco un po’ di garza e poi la pressò coi polpastrelli, come a tamponare una ferita. Se non più lontana, e più innocua, la guerra a un tratto parve più ovattata.
Pensò al transatlantico olandese che era stato sventrato da una mina al largo della costa inglese, non più di due o tre giorni prima: ne aveva parlato il giornale. Lui si era perso a immaginare lo squarcio spaventoso nella chiglia, i relitti schiaffeggiati e infine arresi, il mare che si apriva e richiudeva in una voragine imperiosa.
Erano morti tutti, a bordo. Tutti. Centoquaranta persone travolte e sparite in fondo al mare. Giorgio si sentì rabbrividire.
La sua infanzia – la sua estrema giovinezza – non sempre riusciva a proteggerlo. A volte il dolore del mondo – o il suo peso, o la grazia, o la follia – entrava in lui e poi lo sommergeva come l’acqua aveva fatto con la nave. Altre volte lo invadeva una bellezza che lo sguardo non riusciva a contenere. Allora, incastonato sulla retina oppure sprofondato nei pensieri, il mondo bisognava liberarlo: risucchiarlo al di fuori di sé, costringerlo a tornare in superficie. E poi ricomporlo, plasmarlo, scompaginarlo fino nel midollo solo per ricrearlo di nuovo.
Giorgio tolse dalla scatola di latta che conteneva tutti i suoi tesori le conchiglie raccolte in estate, sulla battigia di Grado: le pestò sull’assito col martello fino a ridurle in frammenti, ricavandone una fredda iridescenza che finì per impastare con lo stucco.
Gli parve di sentire nelle orecchie la potente risacca del mare, ma forse non era nient’altro che il pulsare del sangue nelle vene, il fluire regolare del respiro. Con lo stucco impregnato di frammenti riempì infine una crepa del muro – una crepa ondulata come un’onda – e assicurò gli altri oggetti già incastonati nei fori sotto una lastra di vetro, fissando anche quella con lo stucco.
Infine, socchiudendo appena gli occhi, si ritrasse e studiò il suo lavoro. Sassi e conchiglie, bacche e garza bianca, radici imbrattate di fango e qualche piuma che citava un volo. Nel mezzo, una biglia scheggiata. Più in alto, un frammento di iuta. Una babele di vita nello scorcio trasparente di un quadrato.
C’era niente, sotto quel vetro. Solo piccoli scarti senza peso, privi di valore e di importanza.
C’era niente, sotto quel vetro. C’era niente, eppure c’era tutto.
Acqua e cielo, terra e fuoco di passioni. Il corso marginale delle cose, l’eco di luoghi ancora sconosciuti, la provvisorietà dell’esistente, le ipotesi dell’immaginazione.
In un giorno ancora lontano, avrebbero dato molti nomi ai prodotti delle sue mani: folgorazioni figurative, seduzioni simboliche, muri antropomorfi. Nomi difficili, concetti complicati.
Ma la felicità può essere semplice. In quell’umido mattino di novembre, per Giorgio di certo lo era.
Si cinse le ginocchia con le braccia, poggiò il mento sopra un polso abbandonato.
La pioggia ora picchiava alla finestra: Giorgio non se n’era ancora accorto.
Il gatto acciambellato sull’assito volse un attimo la testa, e lo guardò. La zampa grattò un angolo di pelo. Da una trave di legno sul soffitto oscillava una leggera ragnatela.
La luce della lampadina nuda tremò in un nuovo spiffero di vento e accese bagliori sul vetro, rendendo quello spazio un’onda aperta e la biglia in mezzo al muro un occhio vivo.
Antonella Sbuelz